durata: 128’
produzione: Francia / Germania Ovest
cast: Romy Schneider, Harvey Keitell, Harry Dean Stanton, Thérèse Liotard, Max Von Sydow, etc.
sceneggiatura: David Rayfiel, Bertrand Tavernier e Géza von Radványi
fotografia: Pierre-William Glenn
musica: Antoine Duhamel
La capacità di Tavernier di fare fantascienza senza l’ausilio di complessi effetti speciali, ma con la semplicità delle idee – che sembra perpetrare l’amore e dedizione applicate tra le mura del Nickelodéon di vent’anni prima (non a caso sul finale compaiono poster di film di Corman) – porta sullo schermo un romanzo di David G. Compton (“The Continuous Katherine Mortenhoe”) a dir poco profetico per la sua capacità di predire l’involuzione semantica e morale della comunicazione televisiva. Ed è profetico il mestiere della protagonista [Romy Schneider]: programmatrice…di libri con una tecnologia a metà strada tra il perpetrato furto intellettuale dell’AI e la cinica aleatorietà generativa degli sceneggiatori di “Borys”. E analogamente lo è la scena dell’abbraccio del figlio al parco, che perderà da lì a poco nella vita reale, seguendolo circa due anni dopo (nel film casualmente si parla di due mesi di aspettativa di vita) appesantita da un tumore (come nel film) e dopo ipotesi smentite di suicidio (scelta finale di radicale protesta nel film). “La mort en direct” è attuale anche nella sua rappresentazione distopica lontana dalle alterazioni architettoniche e scenografiche di opere simili: fatta eccezione per la metodologia implantiva utilizzata per l’inviato Roddy [Harvey Keitell], assetato di medianica mediaticità, il futuro mostrato è quanto di più simile a quello che ha visto la prima della pellicola; quasi a ricordarci che il male vero (non quello fisico, seguito con morbosa attenzione da una società che non si ammala più, ma quello intellettuale) vive già tra di noi. Vive e si nutre della noia che s’insinua tra i nostri stimoli; così come nella perdita di coscienziosa empatia avulsa dal produttore televisivo senza scrupoli [Stanton], promulgatore di quella che è ormai l’unica forma di ‘pornografia’ (la morte) appetibile per il suo pubblico, capace di spingere la sua versione di moderno reality verso nuovi confini di oscenità (la violazione intima e profonda di una persona malata che si defeca addosso trasmessa in diretta nazionale). Empatia che al contrario sembra logorare gli ultimi attimi di vista di Roddy, edipicamente condannato a una cecità interiore da cui solo quella organica può salvarlo. E diventano metaforiche la sua acluofobia apparente e la dipendenza da una lampadina artificiale che lo preservano da danni permanenti al suo nuovo apparato (tele)visivo. Completano il quadro drammaturgico la solida natura classica e al contempo dissonante del commento sonoro. Musiche che in particolare nell’epilogo catartico ove compare Von Sydow vengono attribuite a un autore ritenuto tanto innovativo quanto sgrammaticato [tale Robert De Bauleac, a lungo cercato da melomani suggestionati dalla fruizione nel film], ma che in realtà – e nuovamente Tavernier allude all’inconsistenza dell’informazione divulgata – appartengono al compositore francese Antoine Duhamel, già collaboratore di Truffaut e Godard.
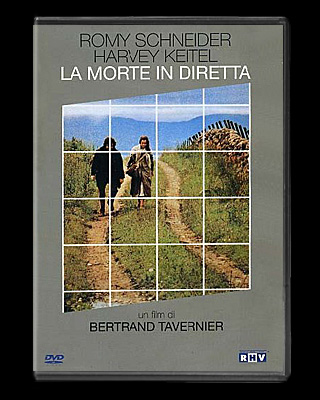
A cura di Luigi Maria Mennella © 2025.
© Articolo di Luigi Maria Mennella. Deposito n° 000TBA presso il Patamu Registry. Tutti i diritti riservati.
© Immagini (utilizzate ai soli fini di divulgazione culturale senza scopo di lucro) dei rispettivi autori, ai sensi dell’art.70 comma 1 bis, art. 70 cit.
Se hai apprezzato questo articolo, sostienimi. Grazie.



